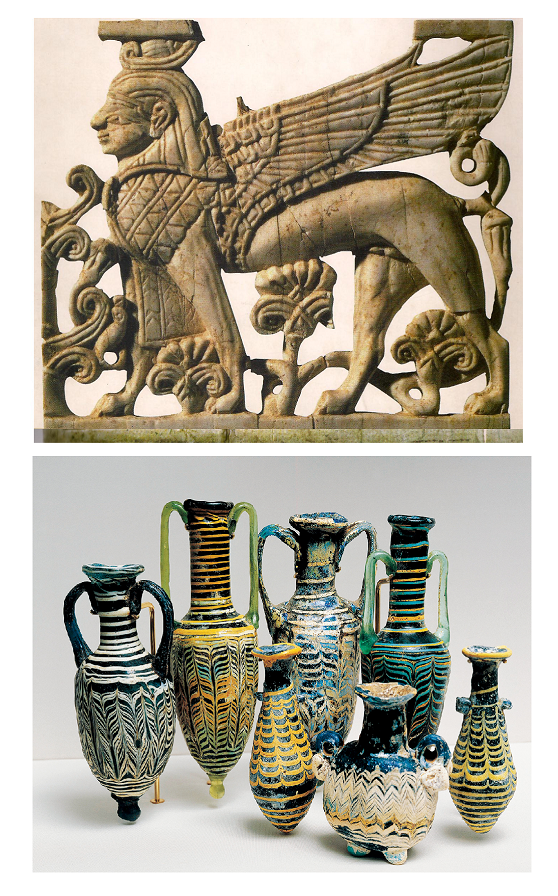
Un tempo, nei paesi della Sardegna, le persone si conoscevano per soprannome, la comunità si reggeva su legami di sangue e di vicinato, e la morte non era ancora un fatto burocratico, ma un evento condiviso. Al calar del sole, poteva capitare che piccole figure femminili, vestite di nero, percorressero silenziose le strade. A queste donne si attribuivano nomi diversi: c’era chi le chiamava “sacerdotesse della morte”, chi “donne esperte”. Per molti, erano semplicemente s’accabadora.
Il termine deriva dallo spagnolo acabar (finire), e il compito di queste donne era proprio quello di accompagnare i moribondi oltre la soglia della vita, quando l’agonia si prolungava troppo. Una sorta di eutanasia ante litteram, che rispondeva tanto alla compassione per chi soffriva, quanto a ragioni pratiche: nelle comunità agropastorali, un malato senza speranza diventava un peso insostenibile per la famiglia, sottraendo tempo e risorse preziose alla sopravvivenza collettiva.
Da sempre ci si interroga sull’esistenza reale di queste figure. Folklore o verità? Già nel 1826, Alberto La Marmora, nella prima edizione del Voyage en Sardaigne, si disse certo della loro presenza nell’isola, ma nel 1839, nella 2° edizione, smorzò i toni, forse per le polemiche suscitate. Tra i suoi interlocutori vi furono l’abate Vittorio Angius, osservatore rigoroso della realtà sarda, e il direttore de L’Indicatore Sardo, Giuseppe Pasella, che lo accusò di screditare il popolo con queste storie.
Seguì un acceso dibattito che, tra accuse e malintesi, contribuì a creare più confusione che chiarezza.
Col tempo, nuove testimonianze alimentarono il mito. Nel 1906, il sacerdote Raimondo Calvisi raccontò di aver assistito, a Bitti, a una conversazione tra la madre di un bambino morente e una donna anziana. Quando quest’ultima offrì il suo aiuto, la madre rifiutò, affermando che il figlio il paradiso se lo sarebbe guadagnato da solo.
Altri ecclesiastici, come il gesuita Giovanni Battista Vassallo, si fecero accaniti oppositori di tale pratica, definendola senza mezzi termini un peccato mortale. Eppure le voci continuavano a moltiplicarsi, con episodi segnalati fino al Novecento: a Luras nel 1929 e persino a Orgosolo nel 1952.
Secondo la tradizione, l’accabadora veniva chiamata solo in casi estremi, quando un moribondo, pur avendo ricevuto l’estrema unzione, non riusciva ad abbandonare la vita. Si riteneva che a trattenerlo potessero essere amuleti protettivi, le pungas, oppure colpe di particolare gravità, come aver spostato una pietra di confine o aver bruciato un giogo, gesti ritenuti offese sacre.
Il rito vedeva la rimozione dalla stanza di ogni oggetto sacro o affettivo, capace di legare il morente alla vita, e gli si poneva accanto un giogo o un pettine, simboli dal forte valore rituale. Se questi gesti non sortivano effetto, la donna ricorreva a strumenti più drastici. Si parlava di un piccolo martello in legno d’olivastro, su mazzolu, con cui finire il moribondo.
Altre fonti parlano di soffocamento. In ogni caso, l’accabadora agiva sempre in solitudine, mentre la famiglia attendeva fuori.
Non riceveva compensi, perché la sua funzione era intesa come un atto sociale, un servizio reso alla comunità. Terminato il compito, si dileguava rapidamente, evitando contatti con i parenti del defunto.
Molti studiosi hanno collegato l’accabadura a pratiche arcaiche di origine rituale. Angius la mise in relazione con il geronticidio descritto da Timeo di Tauromenio, secondo il quale in Sardegna i figli avrebbero messo a morte i genitori maschi al compimento dei settant’anni, in onore del dio Kronos. Altri hanno intravisto un legame con il cosiddetto riso sardonico, l’atroce smorfia che si diceva accompagnasse la morte per avvelenamento rituale.
L’accabadora, dunque, sarebbe l’erede di un antico ruolo sacerdotale, sopravvissuto alla cristianizzazione nelle zone interne dell’isola, e destinato a resistere fino al Novecento, in forme sempre più clandestine.
Col passare del tempo, la figura dell’accabadora ha assunto tratti ambivalenti. Da un lato, simbolo di compassione e di liberazione dalla sofferenza; dall’altro, presenza inquietante, quasi stregonesca, tanto che spesso superstizione e sospetto si estendevano anche alla sua famiglia.
Oggi la sua immagine è oggetto di studi, libri e dibattiti. Alcuni, come Dolores Turchi, sostengono di aver raccolto testimonianze dirette; altri, come A. Bucarelli e C. Lubrano, parlano di eutanasia ante litteram.
Nelle comunità di un tempo, la morte era parte integrante della vita: si sapeva che sarebbe arrivata, e la si affrontava con strumenti sociali e simbolici. La famiglia colpita dal lutto si ritirava temporaneamente dalla vita collettiva, ma veniva sostenuta dalla comunità con gesti di mutuo soccorso.
Oggi la situazione è capovolta. La morte è diventata un tabù, relegata negli ospedali o trasformata in affare politico ed economico. Non se ne parla, e quando arriva coglie impreparati, generando paura e solitudine. Paradossalmente, mentre la società evita il tema, la figura dell’accabadora riemerge con forza nell’immaginario collettivo, alimentando discussioni che ricordano quelle di due secoli fa.
Gli ecclesiastici che un tempo condannavano l’accabadura trovano oggi un’eco nei politici che si oppongono al diritto di scegliere come e quando morire. La tradizione, invece, aveva riconosciuto senza esitazioni quel diritto naturale, che nasceva dal buon senso e dalla compassione.
S’accabadora resta così una figura sospesa tra mito e realtà, fra paura e pietà: non solo “sacerdotessa della morte”, ma anche custode di una libertà profonda, quella di decidere quando la vita, ormai stremata, è pronta a compiersi.
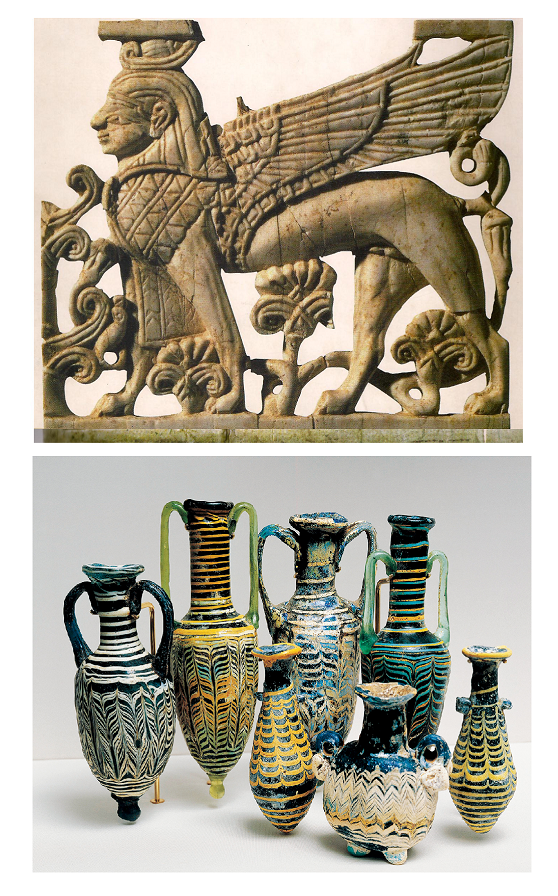


www.sardegnanotizie24.it
è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24
registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018
Editore: Rosso Digitale
Direttore responsabile: Gabriele Serra
Coordinatore della redazione: Claudio Chisu
Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)