
La storiografia tradizionale ha spesso rappresentato Cartagine come una potenza in piena espansione nel Mediterraneo del VI a.C., dominatrice dei mari e padrona della Sardegna. Tuttavia, un riesame delle fonti antiche suggerisce un quadro più complesso: Cartagine non fu sempre in grado di imporre la sua supremazia, e la sua presenza in Sardegna potrebbe essere stata più simile a una convivenza contrattuale che a una vera conquista.
Il mito di una Cartagine invulnerabile viene incrinato dalle testimonianze sugli scontri con i Focesi. Tucidide, Pausania e Giustino ricordano come i Massalioti, fondatori di Massalia (Marsiglia) intorno al 600 a.C., seppero più volte battere i Cartaginesi in mare. Le vittorie furono celebrate con offerte votive a Delfi, segno che non si trattava di episodi marginali.
A ciò si aggiunge il caso di Dorieo di Sparta, che intorno al 525 a.C. tentò di fondare colonie in Africa: il fatto stesso che osasse sfidare Cartagine sul suo territorio testimonia che i Punici non fossero allora imbattibili. Anzi, nello stesso periodo, Cartagine non fu nemmeno in grado di soddisfare le richieste del re persiano Cambise, mostrando una debolezza strategica.
Un momento cruciale è la cosiddetta battaglia del Mare Sardo, nella quale i Focesi affrontarono con successo le flotte etrusche e cartaginesi. Dopo la sconfitta, le due potenze avrebbero “spartito” Corsica e Sardegna. Ma su quale base storica? Le fonti non chiariscono se vi fu un atto di conquista effettivo o piuttosto un accordo di influenza. Parlare di possesso cartaginese della Sardegna, a questo punto, appare eccessivo.
Il nodo principale per comprendere il ruolo cartaginese in Sardegna passa attraverso i trattati stipulati con Roma dove emergono due filoni:
. Tito Livio parla di trattati “vetusti” tra Roma e Cartagine, rinnovati più volte, il primo dei quali risalirebbe al 348 a.C. e fu il primo vero contatto ufficiale tra le due potenze. Seguono rinnovi nel 343 e nel 306, e ancora nel 277, ai tempi di Pirro. Livio sottolinea sempre le visite degli ambasciatori cartaginesi a Roma, con doni come la famosa corona d’oro di 25 libbre, segno di riconoscimento politico.
. Polibio, invece, colloca un primo trattato già nel 509 a.C., subito dopo la cacciata dei re da Roma. Secondo lui, il testo stabiliva limiti precisi per la navigazione e il commercio romano, soprattutto in Sardegna e Libia, territori che i Cartaginesi si attribuivano come propri.
Qui nasce il problema: mentre Polibio vede nei trattati la prova del possesso cartaginese della Sardegna, Livio sembra più prudente e non menziona diritti territoriali espliciti.
Un passaggio del trattato riportato da Polibio è particolarmente significativo: i Romani potevano commerciare in Africa, in Sardegna e nelle zone cartaginesi della Sicilia, ma solo sotto controllo cartaginese e con garanzie sul prezzo delle merci. Questo appare come una forma di protezione commerciale, più che di sovranità territoriale.
Polibio stesso nota la differenza di atteggiamento:
– per la Sicilia i Cartaginesi parlano chiaramente solo delle zone da loro amministrate;
– per la Sardegna e la Libia, invece, rivendicano il controllo dell’intera regione, come se fosse un loro territorio.
Eppure, questa pretesa sembra più un riconoscimento formale ottenuto dai trattati che una realtà militare consolidata. In sostanza, Cartagine si sarebbe garantita il diritto di riscuotere tributi o diritti commerciali in Sardegna, più che esercitare un dominio pieno. Da qui l’idea che i Cartaginesi fossero in Sardegna inquilini paganti, costretti a versare somme nelle casse locali per mantenere il proprio insediamento.
Il quadro storico si complica ulteriormente perché le fonti spesso si contraddicono:
– Polibio raggruppa i trattati in un’unica sequenza, ma probabilmente utilizzava documenti d’archivio in disordine.
– Livio li inserisce invece nel contesto cronologico delle vicende militari, parlando di “rinnovi” più che di trattati del tutto nuovi.
La discrepanza ha generato fraintendimenti: alcuni storici hanno interpretato la versione di Polibio come prova di un dominio cartaginese antico sulla Sardegna, mentre una lettura più attenta mostra che i cartaginesi non possedevano l’isola in senso stretto, ma ne gestivano spazi e commerci dietro compenso.
In estrema sintesi abbiamo una Cartagine meno potente del mito
Tutti questi elementi, ossia le sconfitte contro i Greci, i trattati con Roma e la condizione di “inquilina pagante” in Sardegna, ridimensionano l’immagine di una Cartagine irresistibile e padrona del Mediterraneo nel VI-V a.C. In realtà, dovette spesso negoziare, adattarsi, pagare tributi e stringere accordi, ben lontani dall’egemonia incontrastata tramandata dalla tradizione.
In sintesi, Cartagine in Sardegna più che dominatrice incontrastata, fu un’ospite potente ma condizionata, che dovette riconoscere il ruolo delle comunità locali e versare nelle loro casse una sorta di affitto politico ed economico.


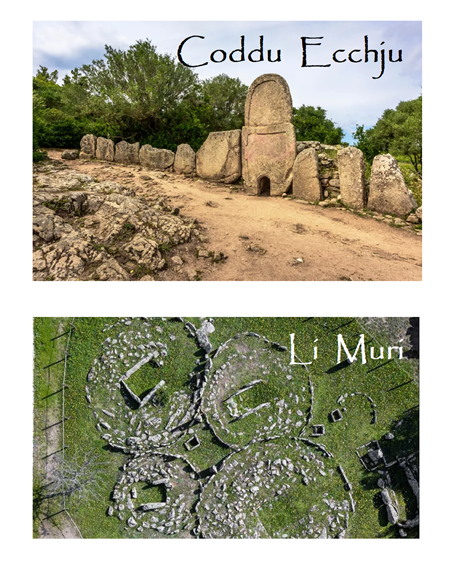
www.sardegnanotizie24.it
è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24
registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018
Editore: Rosso Digitale
Direttore responsabile: Gabriele Serra
Coordinatore della redazione: Claudio Chisu
Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)