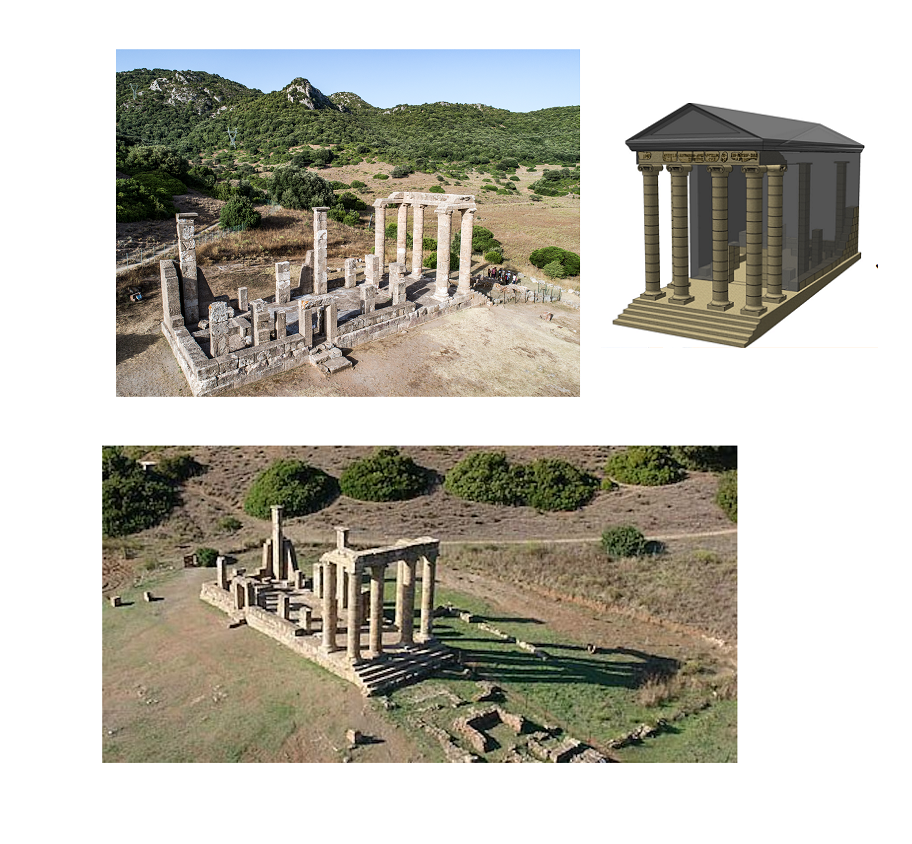
Se c’è uno strumento capace di raccontare la Sardegna meglio di tante parole, questo è senza dubbio le launeddas. Tre semplici canne di fiume, legate da corde e cera d’api, che diventano voce di una tradizione antichissima, arrivata fino a noi quasi senza cambiamenti. Il loro suono continuo, ipnotico e potente, accompagna ancora oggi feste popolari, processioni religiose e momenti di socialità, con la stessa forza di tremila anni fa.
Le launeddas appartengono alla grande famiglia degli aerofoni policalami, strumenti a più canne che hanno parenti in varie culture mediterranee e mediorientali. I loro “antenati” si ritrovano già nell’antico Egitto e in Mesopotamia, ma in Sardegna questo strumento ha assunto una forma tutta sua, rimasta quasi invariata nei secoli.
Sono composte da tre canne principali:
. su tumbu, la più lunga, che produce una nota di base costante, come un bordone;
. sa mancosa manna, che accompagna con ritmo e armonia;
. sa mancosedda, più corta, che porta la melodia principale.
Le due canne melodiche hanno piccoli fori quadrati che il suonatore copre con le dita. Uno di essi, detto s’arrefinu, è regolato con cera d’api per intonare alla perfezione le note. Il segreto del suono sta nelle cabitzinas, minuscole ance intagliate, che vibrano con l’aria soffiata dal musicista.
La presenza millenaria delle launeddas in Sardegna è documentata da una scoperta eccezionale: il bronzetto nuragico chiamato “Itifallico”, datato al VI-VII secolo a.C., che raffigura un suonatore con strumenti simili. Ritrovato nelle campagne di Ittiri e reso noto dall’archeologo Antonio Taramelli nel 1907, è una delle prove più antiche di questo strumento.
Ciò significa che le launeddas non sono un’invenzione recente del folklore, ma una vera e propria eredità preistorica, che ha attraversato epoche, dominazioni e trasformazioni senza mai sparire.
Chi ascolta le launeddas rimane colpito soprattutto da una cosa: il suono non si interrompe mai. Per minuti, ore, persino intere giornate di festa, la musica scorre come un fiume in piena.
Questo miracolo tecnico è reso possibile da una tecnica chiamata respirazione circolare o “fiato continuo”. In pratica, il musicista accumula aria nelle guance e la spinge nello strumento mentre, contemporaneamente, inspira dal naso. Così riesce a non interrompere mai il flusso.
Per chi osserva dall’esterno sembra quasi magia. Non a caso, molti suonatori tradizionali hanno alimentato il mito della difficoltà, presentando questa abilità come un dono raro, da veri maestri.
Tradizionalmente le launeddas accompagnano due momenti fondamentali della vita sarda: la festa religiosa e la festa profana.
Nelle chiese e nelle processioni, le launeddas hanno dato colore alla liturgia, sostituendo in parte gli organi o accompagnando i canti popolari. Ma è nelle piazze, durante i balli collettivi, che lo strumento ha espresso tutta la sua forza.
Il repertorio è organizzato in moduli melodici chiamati is nodas che il suonatore rielabora continuamente. Non esiste un’esecuzione identica all’altra: ogni performance è un intreccio di memoria e improvvisazione, in cui il musicista mostra la sua creatività senza tradire la tradizione.
Chiunque abbia assistito alla sagra di Sant’Efisio a Cagliari ha visto e sentito le launeddas in azione. Decine di suonatori aprono la processione con il loro suono avvolgente, che accompagna il santo lungo il suo cammino verso il mare. È uno dei momenti più emozionanti della festa e una delle occasioni migliori per ascoltare dal vivo lo strumento.
Oltre a Sant’Efisio, in moltissimi paesi della Sardegna meridionale le launeddas sono ancora protagoniste delle feste patronali, confermando il loro ruolo sociale e comunitario.
Negli anni Settanta le launeddas rischiarono di scomparire. La modernizzazione della società e l’abbandono delle tradizioni rurali avevano ridotto l’interesse per questo strumento. A salvarle furono due grandi maestri: Luigi Lai e Aurelio Porcu, che con la loro dedizione hanno formato nuove generazioni di suonatori
Oggi, grazie anche alle scuole di musica e a una nuova curiosità verso le tradizioni, lo strumento vive una stagione di rinascita. Giovani musicisti lo studiano non solo per il repertorio tradizionale, ma anche per sperimentare contaminazioni con altri generi, dal jazz alla world music.
Le launeddas sono da ascoltare e da vedere. Alcuni esemplari si trovano nei musei etnografici e nelle collezioni private, come quelle di Roberto Corona e Orlando Mascia. I grandi suonatori, inoltre, possiedono numerosi strumenti, ciascuno accordato in tonalità diverse.
Accanto ai musicisti, resistono anche i costruttori artigiani: maestri come Giulio Pala, Luciano Montisci e Luigi Pili continuano a tramandare i segreti della costruzione, scegliendo le canne giuste, lavorando con precisione e rispettando tecniche antiche. Senza di loro, la tradizione rischierebbe di spegnersi.
Più che un semplice strumento musicale, le launeddas sono un simbolo della Sardegna. Racchiudono in sé il legame con la terra, con le feste, con il respiro stesso della comunità. Il loro suono continuo è diventato metafora di una cultura che non si interrompe mai, che attraversa i secoli senza spegnersi.
Oggi, ascoltare le launeddas significa fare un viaggio nel tempo: tornare ai riti nuragici, alle danze nelle piazze dei villaggi, alle processioni che uniscono fede e tradizione. Ma significa anche guardare al futuro, con la certezza che questo strumento continuerà a vivere, rinnovandosi senza mai perdere la sua anima.
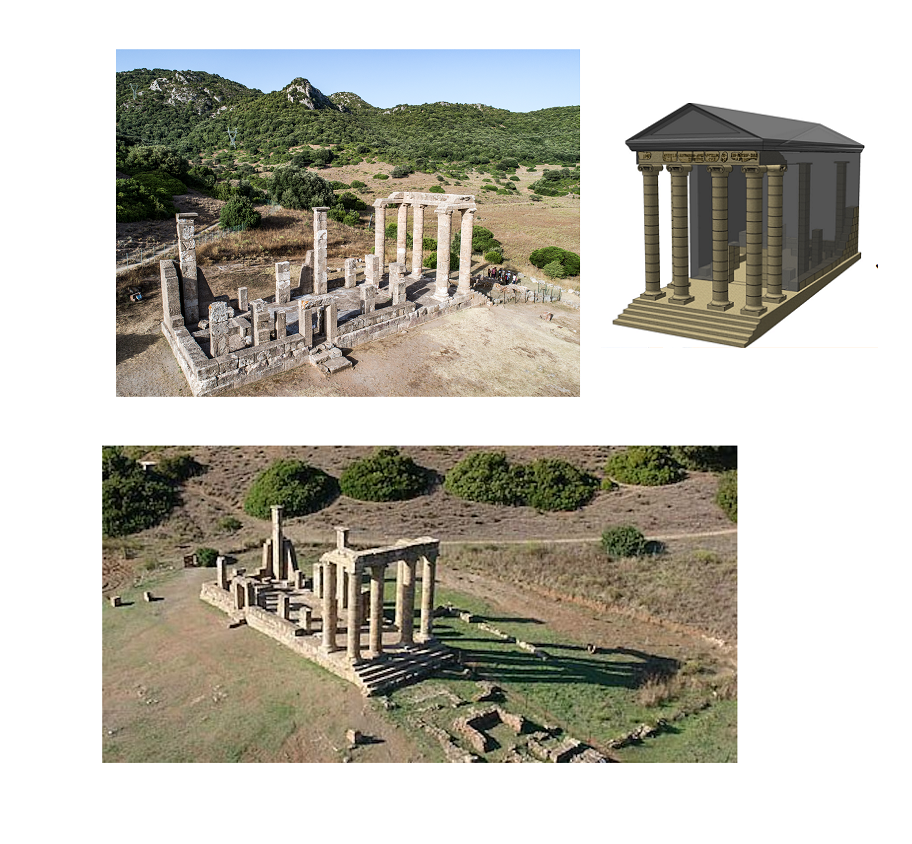


www.sardegnanotizie24.it
è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24
registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018
Editore: Rosso Digitale
Direttore responsabile: Gabriele Serra
Coordinatore della redazione: Claudio Chisu
Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)