
La Gallura, regione settentrionale della Sardegna, conserva un ricco patrimonio archeologico legato alle pratiche funerarie preistoriche e protostoriche. Tra queste, i tumuli e le tombe megalitiche rappresentano elementi centrali di una tradizione che unisce funzionalità pratica, ritualità e credenze religiose. Il tumulo, accumulo di terra e pietre a ricoprire le sepolture, svolgeva una duplice funzione: da un lato stabilizzava le strutture tombali, dall’altro costituiva un potente simbolo legato ai riti di passaggio e alla concezione del sepolcro come “casa dei morti”.
Una delle testimonianze più antiche del fenomeno in Gallura è la necropoli di Li Muri (Arzachena), scavata nel 1939-40 da Puglisi e Soldati. Il sito è composto da tombe a cista litica, ossia piccoli vani rettangolari in lastre di pietra, ciascuno originariamente ricoperto da un tumulo. Attorno alla base si trovano circoli litici formati da lastre infisse verticalmente.
Gli elementi accessori sono di grande importanza rituale: piccole cassette per offerte e menhir aniconici, posti all’interno o all’esterno dei circoli. È probabile che tali strutture fossero predisposte per i riti funebri immediatamente successivi alla sepoltura, e non per pratiche di culto periodiche. L’effetto complessivo della necropoli, con i tumuli addossati l’uno all’altro, doveva essere quello di una serie di piccole collinette artificiali, a rafforzare il carattere sacro del paesaggio.
Gli elementi accessori sono di grande importanza rituale: piccole cassette per offerte e menhir aniconici, posti all’interno o all’esterno dei circoli. È probabile che tali strutture fossero predisposte per i riti funebri immediatamente successivi alla sepoltura, e non per pratiche di culto periodiche. L’effetto complessivo della necropoli, con i tumuli addossati l’uno all’altro, doveva essere quello di una serie di piccole collinette artificiali, a rafforzare il carattere sacro del paesaggio.
Non mancavano sepolture isolate, come quella di La Macciunitta, sempre ad Arzachena, che presenta caratteristiche analoghe. Le ciste erano destinate a una o due deposizioni primarie: il vano non era più accessibile dopo l’inumazione, segno che si trattava di tombe chiuse e definitive. Lo scavo della tomba 4 di Li Muri documenta due livelli di deposizione separati da lastroni orizzontali: i corredi comprendevano mazze in steatite, utensili in selce e ossidiana, amuleti, vaghi di collana e vasellame, spesso con tracce di ocra rossa, sostanza simbolica legata alla rigenerazione.
La disposizione delle tombe, quattro ravvicinate e una isolata, e le differenze strutturali della tomba 5, assimilabile a una camera funeraria più che a una semplice cista, indicano una certa varietà tipologica e un’evoluzione interna. Questa diversificazione segna il passaggio dalle sepolture individuali a forme che si avvicinano a quelle collettive, come avverrà più tardi con i dolmen e le allées couvertes.
La Gallura, separata dalla Corsica da appena otto miglia di mare, mostra forti affinità con i monumenti funerari corsi, come le tombe “en coffre” di Porto Vecchio o i complessi di Poghjaredda e Capu di Logu. Anche i corredi funebri, come i pomi sferoidi in steatite e i vaghi di collana ad olivella, rientrano in un comune orizzonte culturale corso-gallurese del Neolitico medio, precedente alla cultura di Ozieri.
Il confronto con altri complessi sardi, come Pranu Muttedu (Goni), evidenzia differenze sostanziali. Se lì troviamo ipogei articolati (domus de janas) con corridoi e celle, la necropoli di Li Muri è più semplice e “megalitica”, priva di ipogeismo. Ciò suggerisce che la Gallura avesse una sua specifica vocazione culturale, più affine al megalitismo occidentale europeo che all’ipogeismo diffuso nel resto dell’isola.
La successiva comparsa in Gallura di dolmen e allées couvertes, come a Luras, conferma l’inserimento della regione nel circuito del megalitismo mediterraneo e atlantico, distinto dalla tradizione ipogeica tipica del sud e del centro dell’isola.
Con l’età nuragica, il tumulo rimane un elemento essenziale nelle grandi tombe collettive note come tombe di giganti. Si tratta di evoluzioni delle allées couvertes, caratterizzate da lunghi corridoi funerari coperti da lastroni e da una grande esedra semicircolare antistante, destinata ai riti comunitari.
Due esempi celebri si trovano ad Arzachena: Coddu Vecchiu e Li Lolghi. La prima mostra un’allée couverte a cui, in età nuragica, fu aggiunta l’esedra; la seconda è monumentale e racchiusa da un vasto tumulo che ingloba strutture più antiche. Lo scavo ha documentato la rimozione di grandi quantità di terra e pietre, a dimostrazione che in origine la tomba era completamente ricoperta.
Il tumulo, oltre alla funzione statica, aveva una valenza simbolica: la collina artificiale creava un paesaggio sacro e accentuava la monumentalità del sepolcro. L’interazione tra tumulo ed esedra è evidente, come nella tomba di Pascaredda (Calangianus), in ottimo stato di conservazione: il corridoio, la copertura a lastroni e l’esedra monumentale erano interamente inglobati da un tumulo di terra e pietre. Alcuni indizi fanno pensare a sistemi di accesso dall’alto, tramite rimozione parziale della copertura, piuttosto che attraverso i piccoli portelli delle stele. Ciò spiegherebbe la disposizione disordinata degli scheletri nelle tombe di Lu Brandali e La Testa, segno di successive riaperture.
L’insieme dei dati suggerisce che la Gallura abbia sviluppato una tradizione funeraria autonoma rispetto al resto della Sardegna. L’assenza di domus de janas, la preferenza per il megalitismo, i rapporti con la Corsica e con il mondo europeo neolitico e protostorico delineano un quadro peculiare.
Il tumulo, costante dai circoli di Li Muri fino alle tombe di giganti nuragiche, non è solo un espediente architettonico, ma un potente simbolo culturale. Esso rappresenta il legame tra comunità e antenati, la trasformazione della natura in paesaggio sacralizzato, la continuità tra morte e vita.
La Gallura appare quindi non come un’area periferica, ma come un crocevia culturale del Mediterraneo preistorico, capace di rielaborare modelli esterni e di produrre forme originali, riconoscibili ancora oggi nei suoi monumenti funerari.


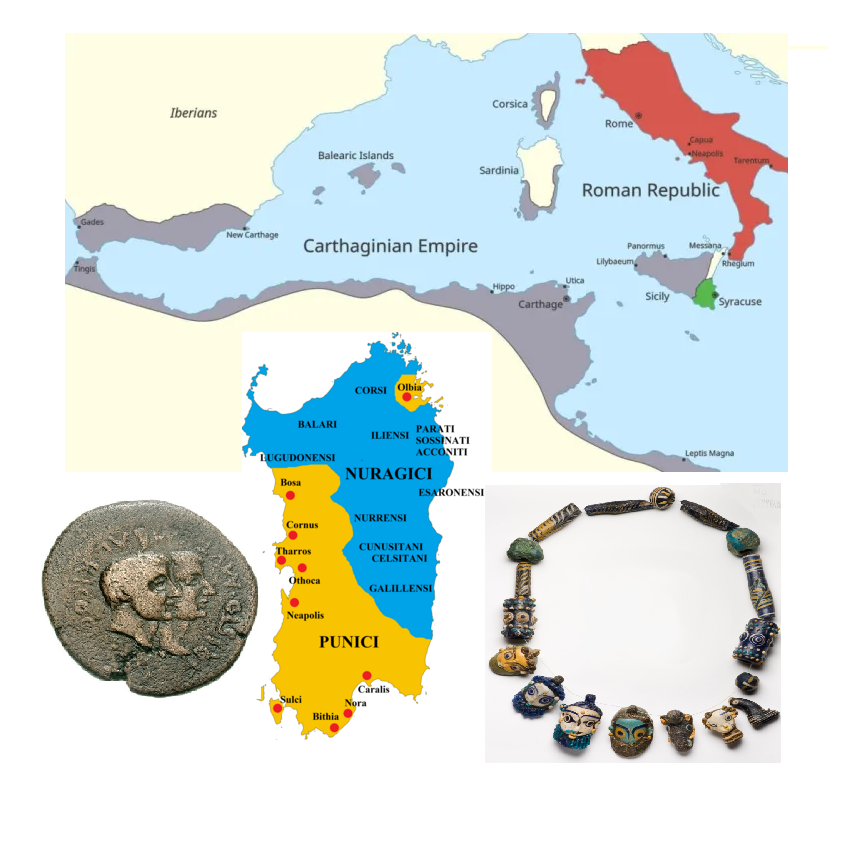
www.sardegnanotizie24.it
è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24
registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018
Editore: Rosso Digitale
Direttore responsabile: Gabriele Serra
Coordinatore della redazione: Claudio Chisu
Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)