
Il calendario sardo è fitto di sagre e feste che accompagnano l’anno intero, diradandosi solo negli ultimi giorni di Carnevale e durante la Quaresima, per poi rifiorire con i solenni riti della Settimana Santa. Le sagre costituiscono il cuore del folclore isolano: celebrandosi nei luoghi d’origine e coinvolgendo gruppi in costume tradizionale, offrono l’occasione di vivere la cultura sarda nella sua forma più autentica.
La radice di molte di queste feste è religiosa: spesso nascono come ex voto, individuali o collettivi, per invocare la cessazione di calamità naturali, epidemie o invasioni. Non mancano i casi in cui furono ispirate da ritrovamenti leggendari di immagini sacre. In ogni caso, accanto al rituale cristiano sopravvivono elementi di culto pagano, che testimoniano la persistenza di antiche credenze.
Il legame con l’agricoltura, forza trainante della vita isolana, è evidente nei riti propiziatori per la fertilità della terra. Come osservava Salvatore Cambosu, la partecipazione popolare non era tanto un’occasione di svago, quanto un modo per “stordirsi, per nascondere l’ansia e la cupezza nel tumulto e nell’allegria rumorosa”.
Molti riti si collegano a culti antichissimi, risalenti persino all’età nuragica. Il culto fallico, testimoniato dai numerosi betili disseminati nelle campagne, si protrasse fino al Settecento, quando il cattolicesimo riuscì solo in parte a sovrapporsi a tali pratiche. Ne resta traccia nei grandi falò (tuvas) accesi per Sant’Antonio Abate e San Giovanni Battista, così come nei riti di comparatico con le canne fresche (cannas friscas), chiaro retaggio del culto del fuoco.
In Barbagia, il culto delle pietre si è spinto fino ad associare affioramenti rocciosi a impronte leggendarie della Vergine, segno di come i barbaricini abbiano conservato più a lungo intrecci fra religione pagana e cristiana. Simile è il discorso per il culto dell’acqua: fonti e sorgenti erano considerate taumaturgiche già in epoca precristiana, e in seguito riconsacrate al culto mariano. La Madonna d’Itria, ad esempio, deriva dalla Hodighítria bizantina, a sua volta legata al simbolismo delle acque.
La maggior parte delle sagre sarde si sviluppò durante la dominazione bizantina (VI-VIII secolo), assumendo tratti simili ai rituali ortodossi greci: processioni, rappresentazioni sacre, banchetti, pernottamenti presso le chiese campestri. In origine, persino balli rituali e corse di cavalli si svolgevano all’interno dei luoghi di culto, con la partecipazione diretta dei vescovi.
Queste usanze, tuttavia, incontrarono l’ostilità della Chiesa di Roma, che nei secoli tentò ripetutamente di reprimerle. I sinodi di Sassari, Torres, Cagliari e Ampurias condannarono le feste comunitarie, i banchetti e le veglie miste nei templi, considerandole profanazioni. Nonostante i divieti, le tradizioni sopravvissero a lungo: a Sindia, per la festa di San Demetrio, i riti comunitari si conservarono fino al 1936.
Accanto all’eredità bizantina, altre pratiche si radicarono nel periodo aragonese-catalano. Una delle più suggestive è sa ramadura, il lancio di fiori e foglie al passaggio delle processioni, che in alcuni casi assume forme più complesse, come la costruzione di tettoie di frasche sotto cui danzare.
La religiosità popolare sarda è sempre stata intensa e appassionata: i santi sono percepiti come protettori e vessilli identitari. Tra i più venerati, Sant’Efisio, difensore di Cagliari dall’assalto francese del 1793, San Lussorio e San Gavino. A essi si affiancano santi “importati” come Costantino e San Giorgio, e un’infinità di figure mariane, spesso legate a titoli locali – da Nostra Signora di Bonaria a quella di Monserrato, da Zuradili a Intermontes.
Un inno popolare, Deus ti salvet Maria, esprime con parole semplici e con una musica intensa la devozione dei sardi verso la Vergine, considerata madre, guida e custode di grazia.
L’organizzazione delle sagre comportava, e comporta tuttora, un impegno collettivo. A guidarle era tradizionalmente un obriere o il priore di una confraternita, responsabile del vessillo sacro e della questua necessaria a finanziare la festa successiva. In Gallura, i comitati organizzatori (soprastàntie) variavano d’importanza a seconda delle risorse messe a disposizione.
Le offerte servivano non solo a sostenere i riti, ma anche ad accogliere i pellegrini, che spesso giungevano per sciogliere voti personali. Intorno alle chiese campestri sorsero nel tempo le cumbessìas o muristènes, piccole abitazioni destinate ai novenanti.
Oggi, questo patrimonio di fede e tradizione viene sempre più valorizzato: le comunità cercano di ricostruire costumi e rituali con fedeltà storica, affinché le sagre continuino a essere, non solo feste popolari, ma anche custodi vive delle radici spirituali della Sardegna.


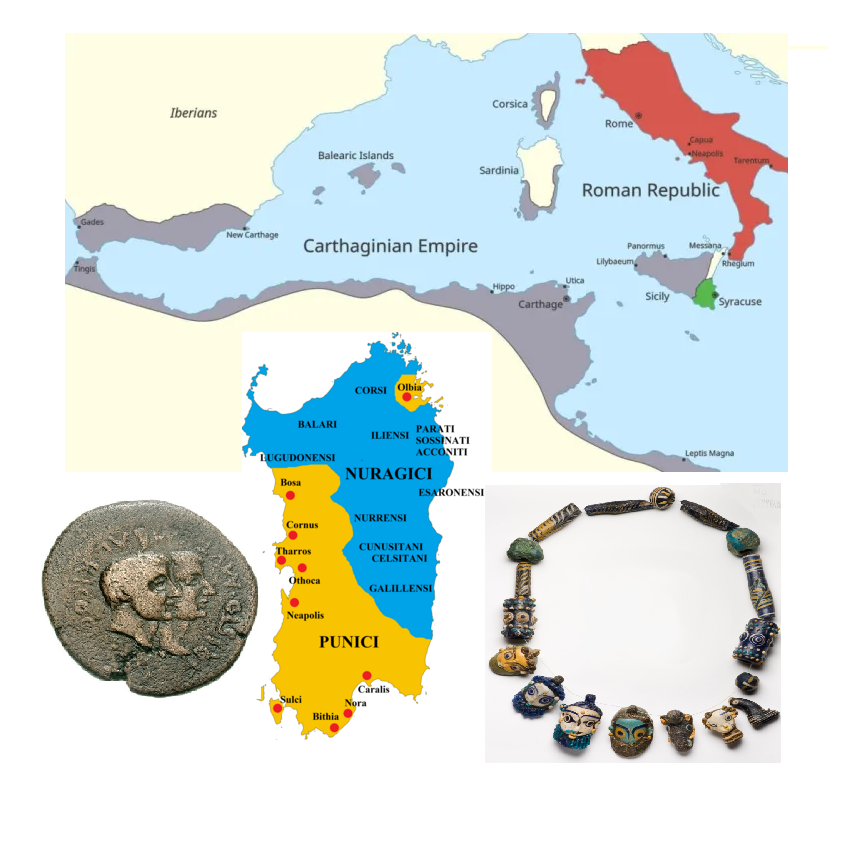
www.sardegnanotizie24.it
è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24
registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018
Editore: Rosso Digitale
Direttore responsabile: Gabriele Serra
Coordinatore della redazione: Claudio Chisu
Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)