
I menhir, o perdas fittas, come vengono chiamati in Sardegna, sono tra le più enigmatiche testimonianze della preistoria. Misteriosi, imponenti, silenziosi: sono legati a un mondo sacro che ancora oggi è difficile comprendere. Nonostante se ne siano censiti quasi 800 solo in Sardegna, e oltre 120 nel sud della Corsica, il loro significato rimane avvolto nell’ombra, soprattutto perché ci mancano le chiavi per leggere il linguaggio simbolico con cui furono scolpiti o posizionati.
Ogni menhir fa storia a sé, e proprio per questo un’indagine seria deve partire da un approccio scientifico, lasciando da parte le suggestioni fantasiose. Il primo passo consiste nell’accertare se l’uomo ha effettivamente lasciato tracce sulla pietra: tagli, lavorazioni, forme riconoscibili.
Oltre all’analisi della pietra in sé, è necessario osservare il contesto: si trovano nei pressi tombe, villaggi, nuraghi? Sono posizionati su colli, lungo antichi sentieri di transumanza o presso luoghi sacri legati al culto dei morti? Il paesaggio attorno aiuta a comprenderne la funzione originaria.
Nel mondo antico, orientale come occidentale, la pietra era spesso usata per comunicare: un bassorilievo, una forma simbolica, un’arma scolpita, tutto poteva avere un valore di messaggio. In particolare, le steli orientali raccontano scene, portano simboli, raffigurano astri o animali, e sono pensate per essere viste e comprese. Anche in Sardegna troviamo menhir scolpiti, talvolta con forme antropomorfe: teste, busti, mantelli, armi come pugnali o spade. Altre volte la pietra appare grezza, apparentemente naturale.
Esistono due grandi categorie di perdas fittas: quelle lavorate dall’uomo e quelle naturali. Le prime possono essere ulteriormente divise in menhir iconici, ossia con figure riconoscibili, e aniconici, cioè privi di raffigurazioni. Alcuni mostrano tratti umani stilizzati: occhi, naso, bocca; altri si limitano a una sagoma allungata con un accenno di testa. Molto interessanti sono i menhir incompiuti, lasciati sul posto dall’artigiano, forse a causa della difficoltà nella lavorazione.
Negli anni Settanta si limitavano le ricerche alla misurazione delle pietre (altezza, larghezza, peso, posizione) ma mancava una riflessione più profonda. Oggi gli studi sono orientati all’aspetto esteriore ma è complicato tentare un’interpretazione funzionale.
Un primo esame può riguardare l’orientamento: molte statue presentano una faccia piatta rivolta verso est. Questo dettaglio, apparentemente secondario, suggerisce un’intenzionalità condivisa, un pensiero simbolico che univa le comunità che le scolpivano. Gli allineamenti, le disposizioni in gruppo o a esedra, la mescolanza tra statue grandi e piccole, antropomorfe e aniconiche, indicano una complessità ideologica ancora tutta da esplorare.
Attraverso uno studio personale condotto sul campo, ho escluso dalla mia analisi i menhir isolati e quelli collocati presso necropoli. Mi sono concentrato su quelli situati lungo antiche vie di transumanza, nei punti di snodo tra villaggi. L’ipotesi che ho elaborato, osservando in particolare il sito di Filitosa, in Corsica, è che gli allineamenti di menhir rappresentassero una sorta di distretto: un’unità territoriale formata da più villaggi che probabilmente collaboravano alla gestione delle risorse.


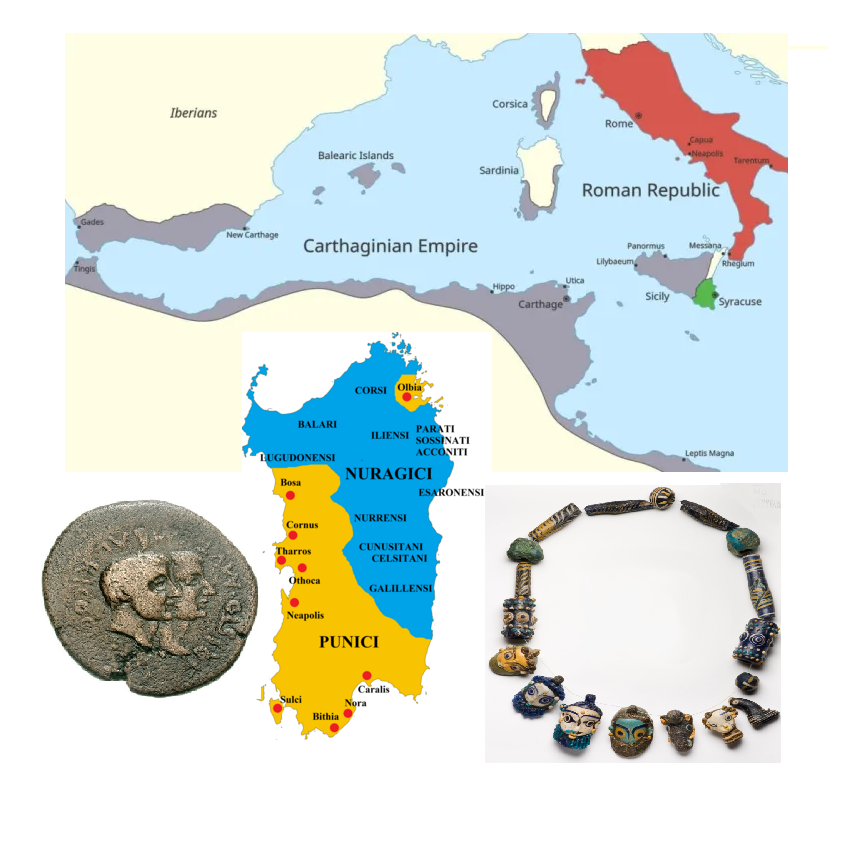
www.sardegnanotizie24.it
è un marchio della testata giornalistica Sardegna Eventi24
registrato presso il Tribunale di Sassari n° 1/2018
Editore: Rosso Digitale
Direttore responsabile: Gabriele Serra
Coordinatore della redazione: Claudio Chisu
Hosting Keliweb s.r.l – Via Bartolomeo Diaz, 35, 87036 Rende (CS)